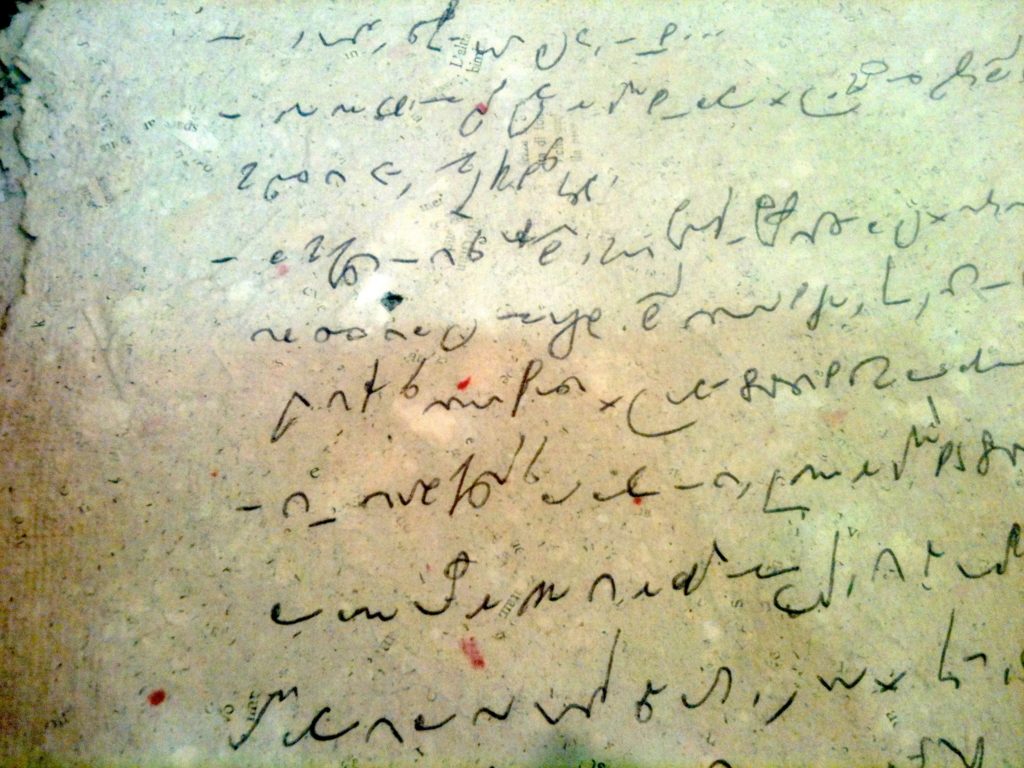Girava una specie di leggenda, a San Salvario. Che prima del Rojo Agro, nella zona ci fosse il deserto.
Si diceva che prima che il locale aprisse i battenti, lì intorno, in tutte le antiche vie del quartiere, la sera “sembrava di essere a Beirut”: nessuno in giro se non spacciatori e relativi clienti, buio, puttane, stupri, furti.
Insomma, ciò che viene comunemente detto “degrado”: l’invereconda esposizione in strada di tutte le attività che, nelle zone non degradate, vengono svolte comodamente al chiuso, in appartamenti coi doppi vetri e l’aria condizionata.
A San Salvario non era stato possibile cancellare il degrado disintegrando qualche palazzo con l’esplosivo come in via Artom. Gli edifici, infatti, erano tutti “di alto valore storico”: bellissimi, eleganti, costruiti uno o due secoli prima. Nessun sindaco, assessore, ingegnere dell’ufficio tecnico del Comune si sarebbe mai sognato di proporre di piazzare 5200 cariche di gelatina di dinamite nelle cantine di un edificio liberty del 1880 al fine di eliminare la vicina attività di meretricio di numero 3 donne di nazionalità albanese e quella di spaccio di eroina e cocaina per mano di numero 4 individui di nazionalità nigeriana e senegalese.
Così, la Storia aveva stabilito di tentare una riqualificazione del quartiere più morbida, permettendo al Rojo Agro di atterrare come un disco volante da cartone animato nel bel mezzo del quartiere, in via Baretti, all’angolo con via Principe Tommaso.
Il locale aveva inaugurato nel 2001, a ottobre, e aveva subito colpito l’attenzione per i suoi colori vivaci e per il personale che ci lavorava. Sullo sfondo delle pareti viola, gialle, cobalto, si affaccendavano a spillar birre, mescere rum, lucidare bicchieri, tre ragazzi giovanissimi, uno ghanese, uno marocchino e uno algerino.
Il gestore invece era italiano, torinese, si chiamava Simone, ed era un uomo di certo oltre i cinquanta ma senza certezza sul seguito, appassionato di sigarette e sguardi malinconici. Fuma- va e guardava senza sosta, guardava e fumava, dispensando tutt’intorno, su muri auto e persone, nubi azzurre di Merit e malinconia per chissà quali bei tempi andati, immobile sul marciapiedi davanti al locale, lasciando ai tre ragazzi la piena, adultissima, responsabilità di gestirlo.
Tutti e tre i baristi provenivano da Crocevia: prima di sbarcare a Crocevia, spacciavano coca, crack, fumo, ma non a San Salvario, bensì in traverse di corso Giulio Cesare o ai Murazzi sul Po, a seconda delle serate. Gli operatori di Crocevia li avevano avvicinati sul loro luogo di lavoro, di notte. Quasi sempre i baby pusher erano ben disposti a fare due chiacchiere veloci (se avevano già imparato l’italiano), ma ben pochi avevano intenzione di parlare. In alcuni casi, però, la pazienza degli operatori aveva la meglio, e qualcuno dei mini spacciatori, dopo un certo numero di visite e di suggerimenti, insistenze, preghiere, cominciava a lasciare il numero di telefono, a passare da Crocevia, a raccontarsi, e allora aumentavano le possibilità che gli operatori riuscissero a estrarlo dal buco nero dello spaccio per depositarlo in comunità e successivamente, compiuta la maggiore età, spararlo nel buco nero del mondo del lavoro.
I tre ragazzi del Rojo Agro, alla soglia dei 18, bisognosi di un lavoro per diventare adulti, maturare, venire responsabilizzati e soprattutto non essere cacciati a calci in culo dall’Italia, erano stati selezionati direttamente da Simone sotto l’attenta supervisione di Gabriele. Proprio Gabriele aveva indicato e vivamente raccomandato all’attempato gestore di club ‒ con mille giri di parole, perifrasi e ammortizzatori verbali ‒ i tre ragazzi che avrebbero creato meno problemi legati alla disciplina.
la scena della selezione sarebbe stata definita da un cinico simile alla scelta di tre schiavi da parte di un proprietario terriero texano nel Settecento, col venditore che mostrava orgoglioso i denti e i muscoli e decantava la raffinata educazione impartita a quelle teste calde per natura. una persona positiva, invece, l’avrebbe definita simile alla scena di un talent show televisivo, in cui tre ragazzi comuni vengono scelti da una giuria per fare la vita che tutti i ragazzi sognano, quella delle star .
la persona positiva si sarebbe avvicinata alla realtà molto di più del cinico: passare da Crocevia al Rojo Agro, difatti, aveva reso la vita di quel trio semplicemente meravigliosa. Lì erano a tutti gli effetti delle stelle: il bancone era il loro palcoscenico e la spillatrice, le bottiglie e il coltello con cui affettavano la frutta per i cocktail, i loro strumenti musicali.
Il locale aveva immediatamente attratto mandrie e mandrie di giovanissimi torinesi in cerca di emozioni forti da vivere nei due minuti di tragitto dalla macchina parcheggiata al locale. Percorrevano in silenzio via Saluzzo, largo Saluzzo, via Baretti, via Sant’Anselmo, via Berthollet, con il cuore che batteva, il cane ben stretto al guinzaglio e la fronte aggrottata di chi è ben conscio di quali sono i pericoli a cui va incontro ma non gliene frega nulla perché la vita va vissuta soprattutto nei suoi lati più oscuri e minacciosi. Purtroppo, la botta di adrenalina più forte che il loro Bronx sabaudo era in grado di regalargli poteva spaziare dal moro che sibilava da un anfratto l’ormai mitologica domanda “tutto a posto?” al tossico che si avvicinava con sguardo implorante cercando di scroccare qualche euro con la patetica, consumatissima, ma sempre perfettamente recitata pièce teatrale intitolata “mi hanno rubato il portafogli ‒ non ho i soldi per far benzina alla macchina ‒ abito subito dopo Novara ‒ aiutatemi”.
Il Rojo Agro apriva intorno alle sette di sera, per l’aperitivo cosiddetto “etnico”: cous cous e tabulè, hummus di ceci, polli e polletti saltati con le spezie, riso venere e riso basmati, pesce kaldou, forme di naan, foglie dawali con la carne, in un tripudio luccicante e vaporoso di cucine dei Paesi in via di sviluppo più tiraturisti del mondo.
Mentre gli avventori mangiavano, Simone si metteva fuori a fumare dando loro le spalle, come se il cibo e lo spettacolo della gente a tavola fossero per lui insopportabili. I picchi di maggiore malinconia li raggiungeva proprio in quegli istanti, quando, praticamente da solo sul marciapiedi, barba grigia al vento, sempre in camicia a prescindere dalla stagione e dalla temperatura, ruotava leggermente il busto in direzione est e fissava languidamente lo sguardo in direzione della collina, lungo l’asse di via Baretti.
Il suo fastidio quando i clienti, dopo l’aperitivo, si riversavano in strada accendendosi le sigarette e cominciando a sorbire drink, non era affatto palese: solo un occhio allenato a osservare i più delicati meccanismi del corpo umano avrebbe notato la sua irrequietezza al cospetto della piccola folla, la perdita della suprema calma conquistata pochi minuti prima, e i suoi frequenti nevrotici viaggi senza scopo fino alla cucina o al gabinetto nel vano tentativo di riconquistarla.
In realtà, Simone era annoiato a morte dagli avventori del Rojo Agro, principalmente per la gigantesca differenza di età (lui cinquanta, sessanta, settanta? loro dai sedici ai venti e qualcosa), e poi per la terribile e compiacente ingenuità con cui alcuni di loro non smettevano di fargli i complimenti per il gesto “coraggioso” che aveva compiuto aprendo un locale a San Salvario e mettendoci dentro a lavorare degli extracomunitari “con un passato difficile”. usavano sempre quelle parole, “coraggioso” e “con un passato difficile”.
Simone annuiva per dire grazie, e poi, inalando ed espirando fumo cominciava la solitaria danza del tabagista, quell’incessante dentro nel cuore ‒ fuori dalla bocca ‒ dentro nel cuore ‒ fuori dalla bocca, pantomima perfetta di una conversazione sincera e profonda con se stessi.
Coraggioso tu? Sei coraggioso almeno quanto sei giovane, si sfotteva. la semplice verità era tutta una questione di licenze: quella del Rojo Agro l’aveva pagata quattro bruschette, visto che a San Salvario si respirava quell’aria di Beirut che terrorizzava anche i torinesi più spavaldi e mai nessuno avrebbe pensato di aprirci nemmeno un chiosco che vendeva arachidi, figuriamoci un localino notturno. Un quartiere con le licenze tanto economiche in un’area tanto centrale era forse un unicum in tutto il mondo (fatta eccezione naturalmente per Beirut): e Simone, stanco di aprire e chiudere baretti e barastri in periferia frequentati solo da anziani logorroici alcolizzati di sambuca e tamarri con lo scooter in cerca di un posto dove scoreggiare gratis, aveva deciso di regalarsi un’ultima, grandiosa possibilità. Quella di aprire un locale diverso, un po’ alternativo, dove poter osservare con dolce tristezza la gioventù del ventunesimo secolo libare, per ricordare con maggiore fedeltà possibile la propria, ormai bell’e che andata.
Tutto questo, spendendo il meno possibile. Anche i tre ragazzi di Crocevia costavano molto poco, con le loro modeste pretese di retribuzione. Per il momento, ai tre barman dei soldi non gliene fregava proprio niente. Del resto, fino a qualche mese prima vagavano per i marciapiedi di Barriera di Milano con palline di cellophane gialle piene di coca in bocca e la paura di venire accoltellati o messi in gattabuia, e di punto in bianco si erano ritrovati a essere tre splendenti icone afro in grado di proiettare ogni sera a un pubblico galvanizzato il film, rassicurante e salvifico, dell’emigrazione felice e ben riuscita.
Alessandro Musto
Questo estratto è parte del primo romanzo dell’autore: Via Artom, Rai Eri (2016), EAN 9788839716668 ed è stato pubblicato per gentile concessione dell’Autore e di RAI ERI.
Per ulteriori informazioni e per acquistare il libro:
https://www.amazon.it/Via-Artom-Alessandro-Musto/dp/8839716661/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1467820879&sr=8-1&keywords=musto+via+artom
Emina Cevro Vukovic ha intervistato Alessandro Musto