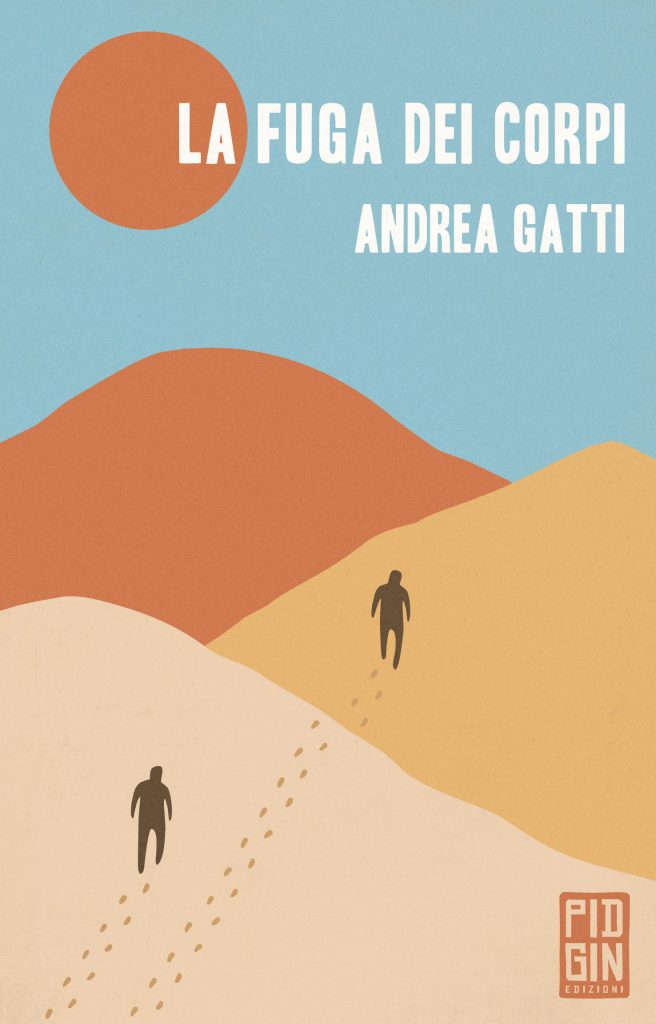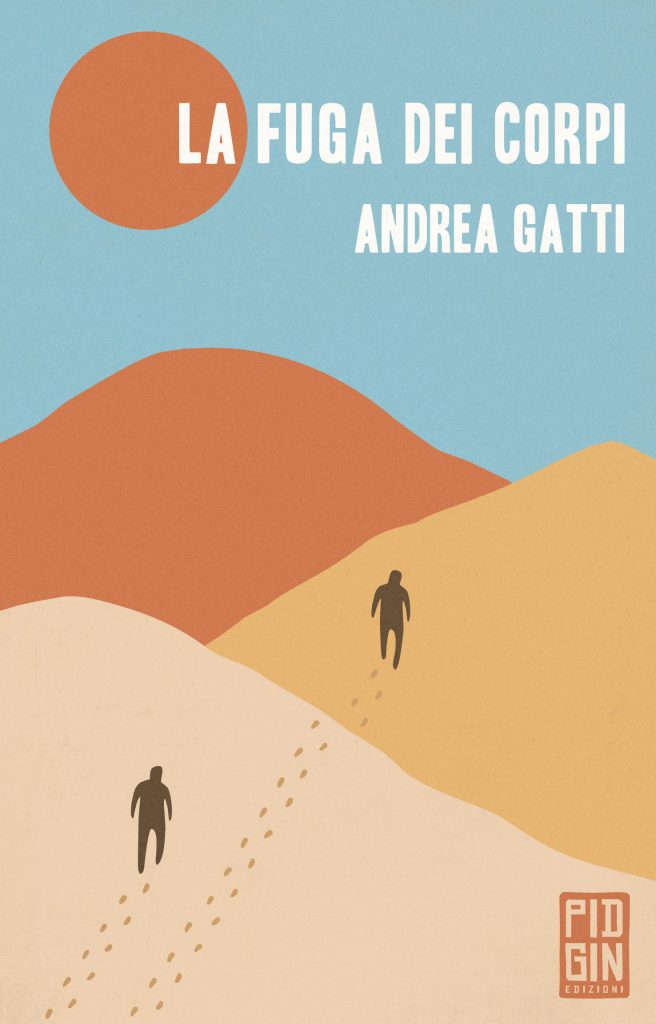(…)
Nel salotto trovo alcune candele. Mi assicuro che la serranda sia abbassata prima di sparpagliarle per la sala e accenderle. Fanno un buon profumo. Appare un televisore (a tubo catodico, con manopola) e una vecchia radio. I servizi da tavola sono riposti in una dispensa a vetri. Ci sono oggetti di un altro mondo, pile di giornali di quando non eravamo nati. Una caramella Herla se ne sta lì sul tavolino, tutta sola. La scarto cercando di non far rumore. Sa di menta fresca.
Mi sdraio a fumare su un materasso che evito accuratamente di guardare. La pioggia ticchetta contro le finestre. Nessuno può vederci. Siamo noi quelli che vedono. Ieri notte Daniel ha detto che agiamo come zecche. Le zecche si arrampicano sugli alberi e aspettano; non vedono, ma sentono il calore del sangue. Si lasciano cadere su un corpo e, se lo centrano, si attaccano. Succhiano. Poi depongono le uova. E muoiono. Se non trovano un corpo, allora, si arrampicano di nuovo sull’albero, e così via. Daniel parla sempre come se fosse implicito il significato di quel che vuole io comprenda; dà per scontato che io capisca. Parla una lingua esoterica. A volte vorrei aprire la sua testa con un bisturi e guardarci dentro. Gli manca mai casa sua?
Un fragore di pentole all’altro lato della casa mi fa sussultare. Grido: Tutto bene? Sì, risponde Daniel. Sono scivolato. Guardo le fiammelle ardere sulle candele. Anche stanotte non riuscirò a prendere sonno.
Mi raggiunge poco dopo con un grosso cilindro di stoffa blu e lo butta ai piedi del materasso.
Cos’è?
Una casa. Una bella casa portatile.
Mi sporgo a vedere meglio e dico: Non capisco.
È una tenda, Vanni. Gli assi, la cerata e i picchetti sono intatti.
Possiamo prenderla?
Certo, dice lui. Dobbiamo.
Ha anche trovato una bottiglia di amaro e la sta versando in due bicchieri di cristallo. Come diavolo faccia a essere sempre così, Daniel, sempre così irriducibilmente Daniel, io non lo so.
Restiamo in silenzio ad ascoltare la pioggia, riempiendoci i bicchieri di tanto in tanto.
È il migliore dei mondi possibili, dice a un certo punto, e la sua voce ha la tipica inflessione di quando è brillo, con le parole trascinate languidamente in avanti come un corso d’acqua che incontra un sasso: la sua r moscia di Romagna antica.
Sta arrivando l’autunno, dico, ma suona come una cosa triste e mi pento subito d’averla detta.
E lui: Passami la mappa.
Apriamo la cartina sul tavolo e seguo l’indice di Daniel mentre ripercorre la strada: l’Aurelia fino a Ventimiglia, dove diventa la Provençale e infine l’Autostrada dei Due Mari; poi la Catalane che si trasforma in Autopista del Mediterráneo e prosegue per tutta la costa fino allo stretto di Gibilterra.
L’Italia sembra un cazzetto penzolante fra le cosce dell’Europa, dice lui, e la cosa mi fa ridere così tanto che a momenti mi strozzo con l’amaro. Poi poggia il dito in fondo alla Spagna e dice: È qui.
Mi sporgo oltre la sua spalla ma vedo solo deserto.
Parco naturale del Cabo de Gata?
Esatto, fa lui. Cala Bruja è qui intorno.
E come la troviamo?
Richiude la mappa e dice: Sarà lei a trovarci.
Sorride, solleva il bicchiere e lo butta giù d’un fiato. Poi si alza ed esce dalla stanza. Lo osservo scomparire nell’oscurità del corridoio. Dovrei seguirlo fisicamente?
Poco dopo riappare con un pentolone e lo poggia a terra. Afferra mappa e candela, poi si siede davanti al pentolone a gambe incrociate e mi fa: Avvicinati.
Il suo volto adesso è tutto rosso. Mi inginocchio accanto a lui.
Poggia il bicchiere, dice. Non c’è più nulla là dentro.
Eseguo; raddrizzo la schiena e mi accorgo del suo sguardo, ancora fisso su di me.
Le cose non sono le cose, dice. Sono altari, cupole, colonne, templi. E noi – solleva la candela – noi dobbiamo dire la messa.
Avvicina la fiamma a un angolo della mappa, e in una vampata l’Europa comincia ad ardere e sfilacciarsi e volare per tutta la stanza come tanti coriandoli impazziti, con la luce che illumina le pareti di questa casa abbandonata che adesso ha l’energia di una bolla di elettricità, di un vulcano in eruzione.
Quando il fuoco si spegne, Daniel apre la finestra per far uscire il fumo. L’aria umida della sera mi rinfresca le braccia.
Ti va di suonare?
Potrebbero sentirci, dico.
Piano piano, fa lui. A volume basso.
Così acconsento a tirar fuori la chitarra dalla custodia e Daniel, che so già cosa mi sta per chiedere, tossisce un paio di volte nel pugno chiuso e dice: Fuga all’inglese. Ti va?
Partire è più coraggioso di restare.
Mi aggiro per la casa studiandone gli infissi, ascoltando le gocce ritardatarie della pioggia cadere in qualche anfratto di là del muro.
Qui un tempo ci abitava qualcuno. Qui ci mangiava, ci faceva l’amore, ci piangeva qualcuno; adesso ci siamo noi che calpestiamo i morti, che camminiamo sulle rovine. Qui c’era qualcuno che adesso non c’è più: ha preso la porta, ci ha poggiato la mano sopra e l’ha aperta, si è fermato, ha guardato dentro un’ultima volta, poi ha chiuso la porta e se n’è andato per sempre, lasciando tutto così com’è.
Dopo essermi sciacquato la fronte al lavandino sbeccato del bagno, con la torcia poggiata di traverso su una mensola, torno in salotto e cado come un sacco di patate sul divano. Mi stiracchio, mi rannicchio, faccio il morto che annaspa. È il mio modo di prendere confidenza con lo spazio. Qualcosa mi fa il solletico. Scopro dei piccoli complessi di fuliggine attaccate alle piante dei piedi come nuvole. Con un gesto li faccio cadere. Rido, mi gratto. Mollo una scorreggia. Un filamento di ragnatela ondeggia perpendicolare dal soffitto. Sembra uno spermatozoo dondolante nel liquido spermatico della stanza.
Daniel?
Ha smesso di russare. Lo spazio assorbe l’eco della mia domanda.
Mi sfilo i pantaloncini e mi copro con un cuscino.
Buonanotte, mi dico.
Prendo sonno ma non so se mi addormento.
Una volta mia madre mi ha detto: Se esci da quella porta non rientri più.
L’ho presa alla lettera.
Andrea Gatti (1992), dal suo primo romanzo pubblicato (con estratto più esteso) su Split.
Per informazioni e per acquistare il libro:
https://www.pidgin.it/prodotto/la-fuga-dei-corpi/